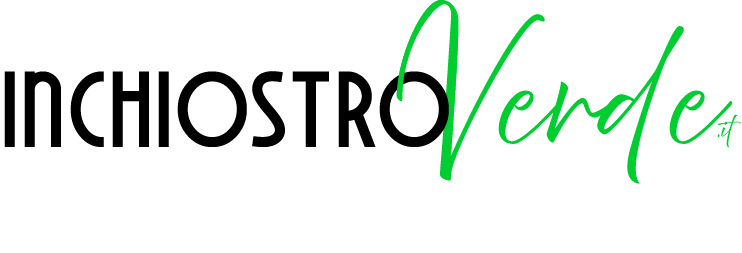Ilva, il docufilm “3×8 Cambio Turno”: un angolo di visuale non è mai l’unico
TARANTO – Un prodotto televisivo sicuramente ben confezionato. L’impronta del giornalista e scrittore Angelo Mellone emerge in ogni frammento del docufilm “3×8 Cambio Turno”, andato in onda ieri su Rai Uno in seconda serata. Fedele alla sua visione, il tarantino Mellone (in collaborazione con Pietro Raschillà) ha voluto raccontare l’Ilva soprattutto attraverso il filtro di chi in quella fabbrica ci lavora.
Ogni singolo tassello del documentario si incastra perfettamente con l’altro: dall’intervento del parroco del rione “Tamburi” a quello dell’ex dirigente Ilva Biagio De Marzo, passando per le opinioni espresse dai giornalisti coinvolti. Nessuna nota stonata rispetto al taglio scelto dagli autori. Una visione decisamente parziale. Le voci dei medici, degli ambientalisti e dei giornalisti più critici nei confronti della gestione passata e presente del siderurgico non trovano spazio. Non si parla delle continue proroghe concesse all’azienda per rispettare le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a cominciare dalla copertura dei parchi minerali.
Per diversi spettatori è come ricevere un pugno nello stomaco. In tanti si indignano lanciando sui Social Network strali acuminati e velenosi nei confronti dell’autore Rai arrivando ad augurargli il peggio. “Ma proprio un tarantino doveva partorire un documentario così filo-aziendalista e filo-governativo?”. E’ la domanda ricorrente. Ammettiamo che anche noi, in più frangenti, abbiamo provato un moto di rabbia e indignazione ascoltando dichiarazioni che riponevano fiducia nell’ambientalizzazione di una fabbrica che ai nostri occhi appare vetusta, ancora troppo pericolosa e irrimediabilmente compromessa.
Ma non è con la denigrazione e la demonizzazione dell’avversario che ci si impone. La demonizzazione è sempre stata un boomerang per chi l’ha utilizzata. Lo stesso errore, talvolta, è stato compiuto nei confronti degli operai, rei di essere complici di un meccanismo infernale che produce malattia e morte. La cinica e disumana contrapposizione ambientalisti-operai ha finito per danneggiare proprio il fronte ambientalista che solo in tempi recenti ha provato a correggere il tiro.
La verità è che l’Ilva rappresenta un problema molto più grande di chi lo gestisce e di chi lo contesta. E’ sempre stato così, dal giorno stesso in cui qualcuno ha pensato di risollevare le sorti del Sud e dell’economia nazionale puntando sull’area che sembrava più strategica per la produzione di acciaio a ciclo integrale. Da allora, non c’è stato un attimo in cui Taranto non sia stata all’interno di un ingranaggio che la vedeva passiva esecutrice di direttive provenienti dall’alto.
E’ vero che il reddito pro capite se ne avvantaggiò rispetto ad altre realtà meridionali. E’ vero che si pose un argine all’emigrazione verso il Nord di tanti giovani e padri di famiglia. E’ vero che grazie all’Ilva fu possibile aprire anche qualche night club (per citare il docufilm della Rai). A mancare, purtroppo, è stata una crescita culturale e sociale capace di consolidare l’identità del tarantino. E lo smarrimento dell’identità non ha colpito solo gli operai, ormai orfani di una coscienza di classe, ma anche gli altri cittadini, quelli che nell’Ilva non ci hanno mai messo piede (volontariamente o meno).
Quelle che vediamo sono le macerie di un percorso che ha visto Taranto incapace di autodeterminarsi. Una comunità che si è aggrappata alle mammelle floride della grande industria di Stato (poi divenuta privata coi Riva) senza mai trovare il coraggio e la curiosità per inventarsi altre opportunità di crescita. E se ciò è avvenuto le colpe non sono solo di chi ha manovrato dall’alto, ma anche di un tessuto umano, economico e sociale che si è fatto manipolare. Possiamo prendercela con Mellone che ci racconta la realtà dal suo angolo di visuale, simile a quello di tanti operai, politici, imprenditori e cittadini che in quella fabbrica vedono l’unica fonte di reddito possibile in un territorio arido, un punto fermo a cui non è possibile rinunciare, anche a costo di pagare pegno in termini di vite umane.
E’ un punto di vista. Non è l’unico. Possiamo indignarci come abbiamo fatto all’indomani del referendum sulla chiusura dell’area a caldo dell’Ilva che ha visto il “Sì” prevalere solo in una minoranza di votanti. O dopo le ultime elezioni comunali che hanno consegnato Palazzo di Città al Pd e ai suoi alleati. Ma è come battere ripetutamente la testa contro il muro. Bisogna prendere atto che esiste anche la Taranto dell’astensione e del “no” alla chiusura delle fonti inquinanti. Sul fronte della consapevolezza c’è ancora tanta strada da fare. Se la città si mettesse davanti ad uno specchio vedremmo riflesse tante anime. L’operaio (fiero o meno di produrre acciaio per la Patria) che si spacca il sedere per garantire un pasto ai suoi figli, l’ambientalista che denuncia l’ennesimo caso di tumore, il cittadino che non se ne fotte né dell’uno, né dell’altro. E forse è di quest’ultimo che ci dobbiamo più preoccupare.