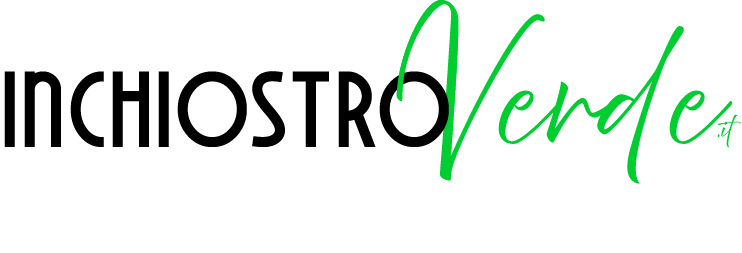Taranto e ambiente: un approccio da cambiare
TARANTO – Già nel 2003 e forse anche prima, la Regione Puglia disponeva di questi dati ricavabili dal Registro Nazionale Emissioni: Taranto e Brindisi dichiaravano nei loro territori le seguenti emissioni industriali (in % rispetto a quelle totali nazionali):
62% di PM del totale nazionale
81% di CO del totale nazionale
23,3% di SOx del totale nazionale
19,6% di NOx del totale nazionale
95% degli IPA del totale nazionale
46% di Benzene del totale nazionale
21,2% di Anidride carbonica del totale nazionale
91,5% di Diossine (solo Taranto) del totale nazionale.
In un territorio amministrato diversamente o in qualche altra parte d’Italia, questi dati sarebbero stati sufficientemente preoccupanti per accendere non uno ma cento campanelli d’allarme sul rischio ambientale e per la salute. Non così dalle nostre parti, dove è dovuto passare un altro decennio prima di far crescere a livello di dibattito pubblico tale drammatica situazione. C’è da chiedersi: cosa è mancato? Una prima motivazione è da ricercarsi nel tipo di approccio all’economia industriale che, in particolare nel Mezzogiorno, sembrava derivare direttamente dalle teorie di fine ‘800 che non tenevano in alcun conto il depauperamento ambientale. La natura era, in pratica una risorsa immodificabile ed inesauribile.
Marx ed Hengel, nelle loro teorie economiche, consideravano il patrimonio naturale un dato invariabile. Lì dove, nelle società più economicamente sviluppate del Nord Europa o di parte del Nord Italia, a partire dai primi decenni del ‘900 cresceva man mano la consapevolezza che il parametro ambientale non poteva più essere ignorato perché incideva direttamente sulla qualità della vita, qui al Sud, complice la miseria ed una endemica necessità di emigrare verso la grande industria del Nord, questo approccio neo-ecologista non fu neanche considerato e anzi, negli anni ’60, fu accolto con grande entusiasmo l’arrivo del siderurgico.
Migliaia di posti di lavoro volevano dire migliaia di emigranti in meno, migliaia di braccianti che non avrebbero dovuto più versare sudore nei campi per sopravvivere. Neanche venne posta all’ordine del giorno la valutazione dell’impatto che la grande acciaieria avrebbe avuto nel territorio da un punto di vista ambientale. Industria era quella di Taranto così come lo era per esempio quella di Torino che addirittura occupava più operai. Sembrava un riscatto per questo Sud fino ad allora agricolo. E neanche si coglieva la differenza tra un’industria di produzione primaria come l’Ilva che produceva acciaio partendo dalla materia prima minerale ferroso e la Fiat che invece lavorava quell’acciaio già prodotto per farne automobili. A Taranto, il minerale doveva fondersi, subire una enorme trasformazione ad un livello energetico decine di volte superiore per acquisire quelle fantastiche e speciali proprietà di durezza, resistenza, durata.
Tanta energia era necessaria in questo processo produttivo, una quantità inimmaginabile di energia utilizzata per produrre le decine e decine di milioni di tonnellate di acciaio che l’Ilva nella sua attività ha utilizzato. Una parte cospicua di questa energia si dissipava nel territorio sotto forma di calore e veniva immagazzinata nelle scorie di produzione che in parte disperse innalzavano il livello entropico causando danno ambientale.
Fino alla fine degli anni ’80, a Taranto ecologia era soprattutto antimilitarismo, lotta alla caccia, protezione della costa (si iniziava a parlare diffusamente di lotta all’abusivismo edilizio) e poco altro. Solo a partire dai primi anni ’90, nella città jonica, si cominciò a formare quella coscienza ambientalista legata più strettamente al territorio e ciò avvenne, per esempio con la nascita di “Caretta caretta” di Fabio Matacchiera e di qualche altro “visionario”, una delle prime, o forse la prima, associazione a livello locale che cominciò a ragionare sull’impatto che Ilva, Marina, Eni producevano sul territorio circostante.
“Caretta caretta” fece scuola e gettò le basi per favorire l’avvicinamento di tanti giovani al tema ecologico che non era dominante malgrado l’oggettiva situazione di forte impatto industriale a Taranto. Ma qualcos’altro è mancato. Il metodo scientifico senz’altro. Ed è strana tale mancanza in questa che fu la patria di Archita, l’ultimo dei Pitagorici, quello che faceva del metodo matematico la base del suo pensiero. Paradossi a parte, è proprio il metodo scientifico che per decenni è mancato nella valutazione di impatto ambientale a Taranto, complice una politica che ha ben evitato la nascita di poli di ricerca ambientale in questa città.
Lì dove, nelle università di mezza Italia, i Dipartimenti di chimica o biologia ambientale facevano a gara per progettare e sviluppare ricerche che dimostrassero contaminazioni da diossine, PCB, metalli pesanti nei più svariati organismi, dalle alghe ai gasteropodi, agli uccelli, ecc., addirittura in sistemi ambientali lontanissimi dalle industrie, come ad esempio al Polo Nord, qui, nella patria della più grande industria d’Europa, nulla si muoveva, nessun laboratorio specifico per questo genere di ricerche nasceva.
E questo ha fatto sì, cosa gravissima, che la salvaguardia dell’ambiente e della salute, diventasse lotta ideologica, contrapposizione di due modi diversi di vedere la società, quando per tanti anni sono mancati i dati oggettivi, quelle analisi scientifiche che avrebbero fatto spostare il fulcro della discussione verso la tutela dei diritti primari di cittadini e lavoratori. A questo si deve porre rimedio. A Taranto deve nascere un polo di ricerca scientifica, all’avanguardia per le indagini sull’inquinamento. A Taranto abbiamo il diritto di sapere, di conoscere ogni minimo particolare circa il livello di saturazione che il sistema ha raggiunto. Le indagini devono riguardare il suolo, le acque, l’aria, i cibi, le piante, gli animali e gli uomini. È una esigenza fondamentale che prescinde da qualunque decisione sul futuro dell’Ilva. È un obbligo nei confronti di un’intera comunità.
Giuseppe Aralla, biologo