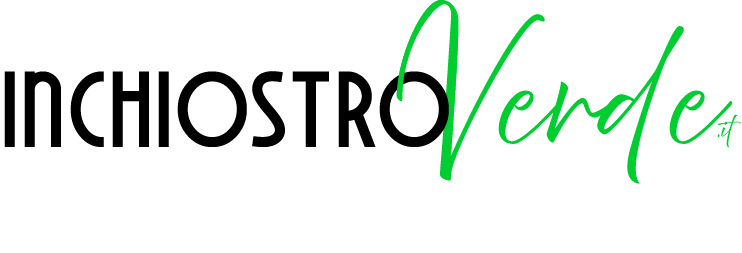L’Ilva e le voci di mercato
 TARANTO – L’impressione è che si stia parlando del nulla. Anche se il momento non è affatto improvvisato. Non è un caso infatti, se le voci di un ipotetico interessamento del colosso indiano Arcelor-Mittal al futuro dell’Ilva, siano state diffuse proprio all’indomani della conversione in legge del decreto 136. Il cui testo conferisce al commissario del siderurgico tarantino, la possibilità di varare un aumento di capitale attraverso tre strade: la richiesta di partecipazione del gruppo Riva, l’intervento di terzi che siano interessati all’acquisto delle azioni dell’Ilva Spa, ed in ultimo la possibilità (tutt’altro che plausibile oltre che “leggermente” anti-costituzionale) di utilizzare le risorse sequestrate al gruppo Riva dalla Guardia di Finanza di Milano per reati diversi da quello di disastro ambientale (leggi frode fiscale) ammontanti a quasi 2 miliardi di euro, investendoli nei lavori di risanamento degli impianti dell’area a caldo del siderurgico tarantino previsti dal piano ambientale (che riprende e posticipa quelli inseriti nel riesame dell’AIA dell’ottrobre 2012) di prossima approvazione.
TARANTO – L’impressione è che si stia parlando del nulla. Anche se il momento non è affatto improvvisato. Non è un caso infatti, se le voci di un ipotetico interessamento del colosso indiano Arcelor-Mittal al futuro dell’Ilva, siano state diffuse proprio all’indomani della conversione in legge del decreto 136. Il cui testo conferisce al commissario del siderurgico tarantino, la possibilità di varare un aumento di capitale attraverso tre strade: la richiesta di partecipazione del gruppo Riva, l’intervento di terzi che siano interessati all’acquisto delle azioni dell’Ilva Spa, ed in ultimo la possibilità (tutt’altro che plausibile oltre che “leggermente” anti-costituzionale) di utilizzare le risorse sequestrate al gruppo Riva dalla Guardia di Finanza di Milano per reati diversi da quello di disastro ambientale (leggi frode fiscale) ammontanti a quasi 2 miliardi di euro, investendoli nei lavori di risanamento degli impianti dell’area a caldo del siderurgico tarantino previsti dal piano ambientale (che riprende e posticipa quelli inseriti nel riesame dell’AIA dell’ottrobre 2012) di prossima approvazione.
Ancelor-Mittal tra conti in rosso e chiusure di impianti
Dunque, il colosso indiano primo produttore di acciaio al mondo, vorrebbe allungare la sua longa manus anche sulla produzione dell’Ilva di Taranto: ma è davvero plausibile una storia del genere? Partiamo da una valutazione meramente economica: difficilmente infatti Arcelor-Mittal potrebbe oggi mettere a bilancio un’operazione del genere.
Andiamo ai dati. La divisione Flat Carbone Europe di ArcelorMittal ha registrato nel quarto trimestre del 2013 una perdita operativa da 366 milioni di euro a causa soprattutto “di oneri di ristrutturazione da 236 milioni dovuti principalmente al piano industriale e sociale su Liegi e alla revisione della produzione primaria di Florange”. Nel terzo trimestre le perdite erano state di 131 milioni di euro. La produzione di acciaio al carbonio è rimasta ferma a 7,4 milioni di tonnellate. Le consegne da 6,7 milioni di tonnellate sono cresciute dell’1,6%, a 6,7 milioni di tonnellate.
Cresciute anche le vendite di acciaio al carbonio che nel periodo hanno raggiunto i 4,83 miliardi di euro (+0,8% su, trimestre precedente). Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato di Flat Carbon Europe, ha dichiarato: “Stiamo vedendo gli effetti positivi di un un’ottomizzazione delle attività e di un miglioramento delle performance operative delle nostre acciaierie FCE nei risultati del 2013. Con un recupero della domanda sottostante di acciaio e un riconsolidamento delle scorte delle fonderie, ci attendiamo di vendere una crescita della domanda europea di acciaio del 2% nel 2014”. Insomma, dati tutt’altro che faraonici.
Non solo. Esattamente un anno fa, era il 7 febbraio, pubblicammo uno dei tanti articoli sul problema della crisi del mercato dell’acciaio in Europa. Il giorno prima, il 6 febbraio, il vicepresidente della Commissione e responsabile per l’industria europea, Antonio Tajani, incontrò una delegazione di sindacalisti del gruppo Arcelor-Mittal, le cui maestranze avevano manifestato a Strasburgo nei pressi del Parlamento europeo. L’1 ottobre del 2012 infatti, Lakshmi Mittal, proprietario di Arcelor-Mittal che controlla il sito siderurgico francese di Florange, in Lorena, chiuse gli altiforni.
La Mittal rilevò nel 2006 la franco-lussemburghese Arcelor ma, guarda caso, non ha mantenuto fede agli accordi sottoscritti al momento dell’acquisizione, che comprendevano anche il mantenimento degli altiforni francesi a Florange, dopo la chiusura dell’impianto di Gandrange. Arcelor-Mittal peraltro chiuse il quarto trimestre del 2012 in rosso di 3,99 miliardi di dollari.
Sui conti del primo produttore al mondo d’acciaio due anni fa però anche e soprattutto “una svalutazione di 4,3 miliardi di dollari sulle attività europee”. Soltanto durante l’intero 2012 Arcelor-Mittal perse 3,73 miliardi di dollari. Ed anche per il 2013, così come per il 2014, Arcelor-Mittal si attendeva “un leggero miglioramento della situazione, anche grazie ad un aumento delle consegne di acciaio del 2-3%”. La crisi del colosso indiano arrivò anche in Belgio, dove Arcelor-Mittal annunciava proprio in quei giorni nuove chiusure di impianti e 1.300 licenziamenti dopo gli smantellamenti avvenuti in Francia.
Perché mai dunque il colosso indiano che altrove in Europa ha chiuso siti simili dovrebbe essere interessato a quello di Taranto? Investendo tra l’altro risorse per il risanamento degli impianti che avrebbe dovuto effettuare il legittimo proprietario oltre che importante competitor in campo europeo?
Costi di gestione e debiti: l’Ilva oggi non è più un affare
Inoltre, fattore tutt’altro che secondario, a Taranto bisogna fare i “conti” nel vero senso della parola. Perché chiunque sia interessato al più grande siderurgico d’Europa, dovrà innanzitutto leggere molto attentamente i bilanci dell’Ilva Spa. Come abbiamo riportato su queste colonne, secondo la Centrale rischi di Bankitalia aggiornata ad ottobre scorso, la società beneficia dagli istituti di credito di un accordato di 1,855 miliardi, dei quali 1,520 utilizzati: di questi ultimi 534 milioni sono autoliquidanti (factoring), 769 milioni a scadenza, 7,3 milioni a revoca, 197 di garanzie commerciali e 14 di garanzie finanziarie (con uno sconfino di 2 milioni).
Togliendo le garanzie, degli 1,3 miliardi residui, Intesa dovrebbe essere esposta per 850 milioni, Banco Popolare per 240, Unicredit per altri 200. Inoltre, nelle scorse settimane abbiamo pubblicato la notizia secondo cui il board triestino Generali, ha appreso di avere una posizione da 180 milioni, tramite un fondo di investimento, nell’Ilva di Taranto. La società di consulenza Kpmg, ha stimato in 111 milioni la “potenziale area di rischio” nell’investimento su Ilva, rischio esponenziale date le condizioni di incertezza estrema in cui versa il colosso dell’acciaio.
Inoltre, pesano come un macigno i costi per la manutenzione degli impianti, che a tutt’oggi sono dati in crescita esponenziale e si aggirano intorno al miliardo di euro. Per non parlare dei 52 milioni di euro del settore stipendi che ogni mese la società sborsa per gli oltre 14mila dipendenti, di cui 11mila occupati nel sito tarantino. Chiunque sia interessato all’acquisizione totale o in parte dell’Ilva Spa, dovrà inevitabilmente fare i conti con questi numeri: che sono tutt’altro che noccioline.
L’ultima parola spetta ai Riva. Prima del definitivo declino
Terzo fattore, che dovrebbe essere in realtà il primo in tutta questa faccenda, riguarda il ruolo e la volontà del gruppo Riva. Perché sino a prova contraria, sono loro a detenere la maggioranza delle azioni dell’Ilva Spa (il 61,62%) pur avendo per tempo staccato la società dalla holding di famiglia. Al di là dei poteri concessi al Bondi dal governo, quest’ultimo per legge è infatti obbligato ad informare la proprietà di ogni singola manifestazione d’interesse: certamente non ha l’autorità per vendere singole azioni o pacchetti azionari a terzi senza il benestare dei Riva. Oltre al fatto che bisognerà tenere in conto anche il parere degli azionisti di minoranza.
Inoltre, la stessa legge prevede che al termine del commissariamento la gestione del siderurgico torni all’attuale proprietà: e, si badi bene, la legge ha stabilito soltanto la durata massima, tre anni, del commissariamento. Ma non è detto che quest’ultimo non possa terminare nel giro di qualche mese, stante la precaria situazione attuale.
Ciò che sta accadendo infatti, è molto semplice. Le banche italiane, quelle esposte finanziariamente nei confronti dell’Ilva Spa, stanno facendo pressione sui più grandi gruppi della siderurgia europea e mondiale affinché investano sul siderurgico tarantino, contribuendo all’aumento di capitale al quale è legato indissolubilmente il risanamento degli impianti dell’area a caldo. Senza le risorse derivanti dall’aumento di capitale infatti, nessun lavoro potrà essere realizzato.
E se ciò accadesse, l’Ilva chiuderebbe nel giro di qualche mese, visto che tutte le leggi varate dallo Stato italiano volte alla sopravvivenza dell’attività produttiva, sono legate al risanamento degli impianti. Sarebbe pressoché impossibile infatti, varare una legge che autorizzi l’Ilva a produrre liberandola dal giogo del risanamento: perché ciò andrebbe anche contro la sentenza della Corte Costituzionale che ha sì salvato la prima legge ‘salva-Ilva’ del governo Monti del dicembre 2012, ma ha altresì stabilito che la produzione dovrà andare di pari passo alla realizzazione dei lavori previsti dall’AIA.
Ma si badi bene anche ad un altro fattore della vicenda Ilva: le pressioni delle banche non sono dovute soltanto al timore di non rientrare dai prestiti concessi in passato alla società. Agli istituti di credito infatti, conviene l’ingresso di nuovi soci e la realizzazione del piano ambientale, in quanto dovranno essere loro a finanziarie quello industriale (2014-2020): come si può facilmente dedurre quindi, in ballo ci sono interessi di vario genere a vari livelli.
Difficile dire oggi cosa sarà e cosa resterà del più grande siderurgico europeo. Certamente la produzione continuerà a calare e diversi impianti saranno spenti definitivamente. Si viaggia dunque a vele spiegate verso un lento quanto inesorabile declino. Dai risvolti sociali ed economici attualmente imprevedibili nella loro futura portata.
Gianmario Leone (TarantoOggi, 11.02.1014)
Ilva, Fiom-Cgil Genova: “Cessione delle aree? Prima pensiamo all’occupazione”
“Prima della vendita delle aree pensiamo all’occupazione, altrimenti le conseguenze sociali e conflittuali saranno enormi”. È l’allarme lanciato da Bruno Manganaro, segretario della Fiom-Cgil Genova, che avverte il governo e le istituzioni locali dei rischi della questione Ilva. Mentre nei giorni scorsi si discuteva la possibile vendita di 100 mila metri quadri di terreno appartenenti all’acciaieria, secondo il sindacalista si è trascurata l’emergenza occupazionale dello stabilimento di Cornigliano, dove – è bene ricordare – su 1740 lavoratori, 1450 sono in contratto di solidarietà fino al 29 settembre.
“Le strade sono due – incalza Manganaro – o il governo fa un decreto con il quale rinnova i contratti di solidarietà, oppure partono gli investimenti per la banda stagnata. Per questa seconda possibilità, però, servono subito 150 milioni di euro. E visto che l’azienda è commissariata, non credo che i Riva ce li vogliamo mettere”. Sulla questione della banda stagnata, poi Manganaro punta il dito contro il collegio di vigilanza composto da Regione, Comune, Provincia e prefetto che, in base all’accordo di programma del 2005, avrebbe dovuto verificare l’avvio degli investimenti.
“L’accordo prevede la continuità lavorativa e salariale dei lavoratori – conclude il segretario della Fiom – dieci anni fa abbiamo fatto un patto, ci siamo presi un impegno davanti alla città. Avremmo chiuso la fusione a caldo ma non avremmo lasciato per strada nessuno”.